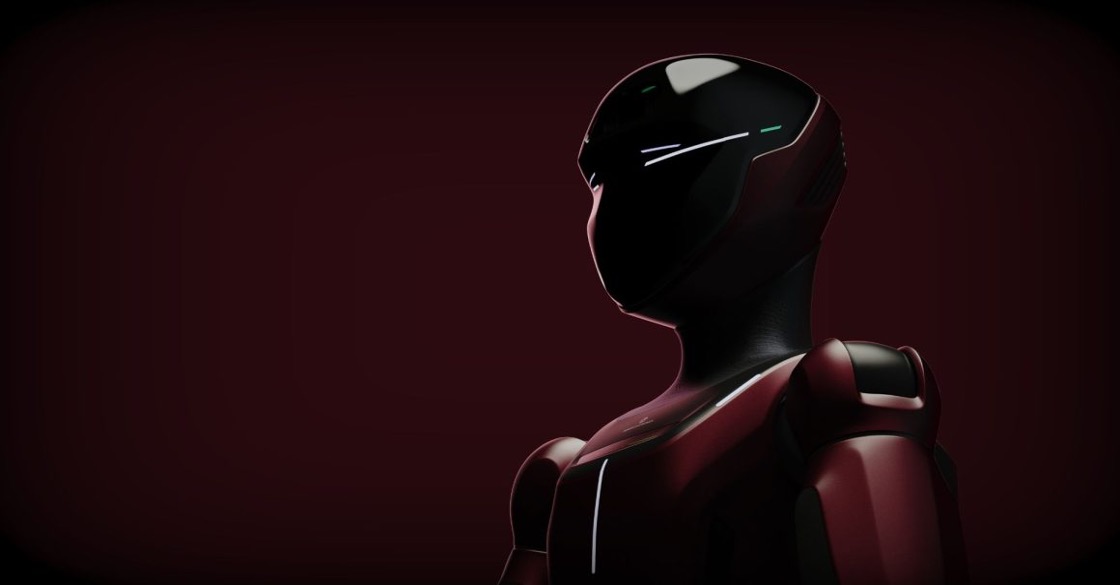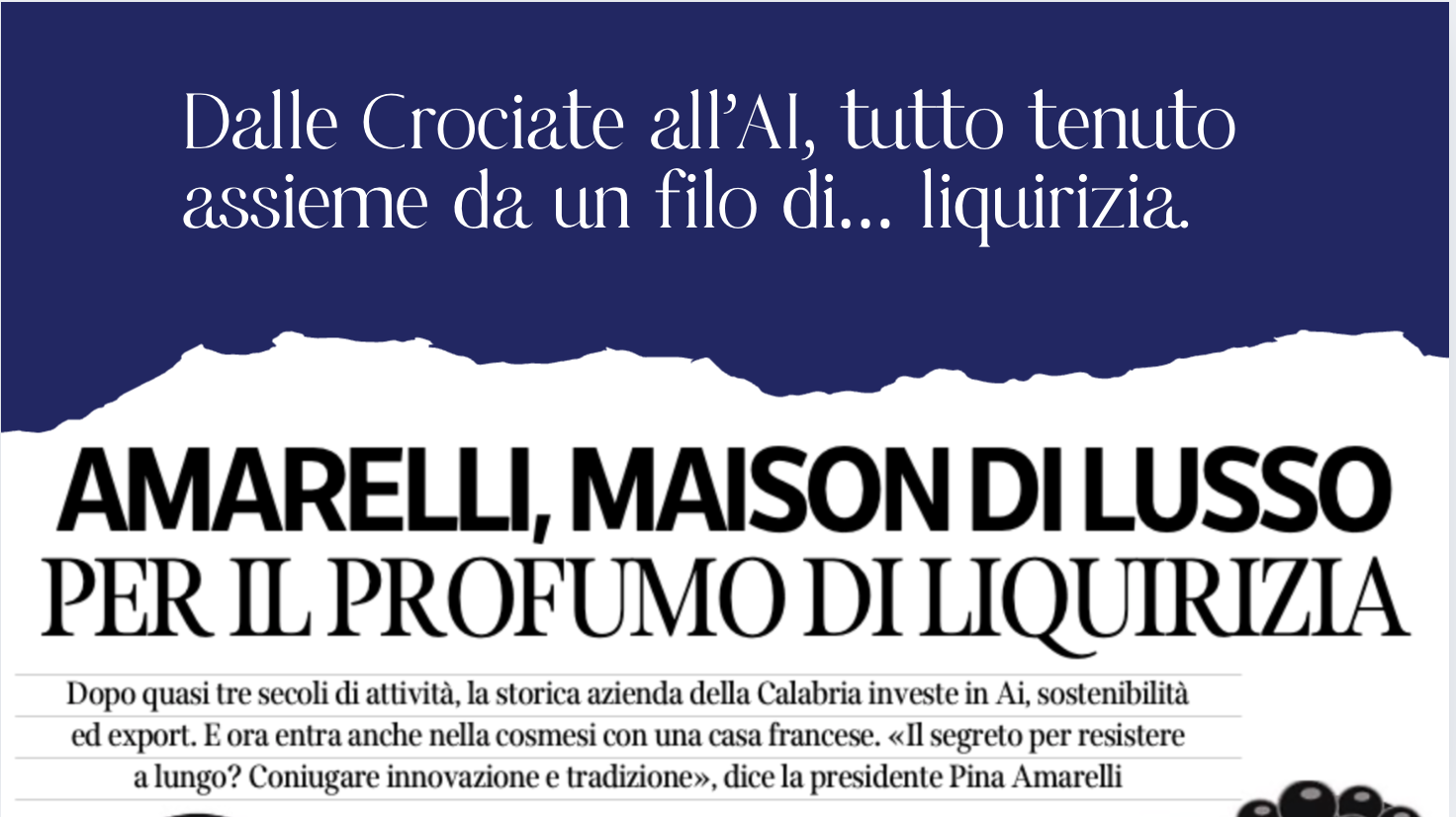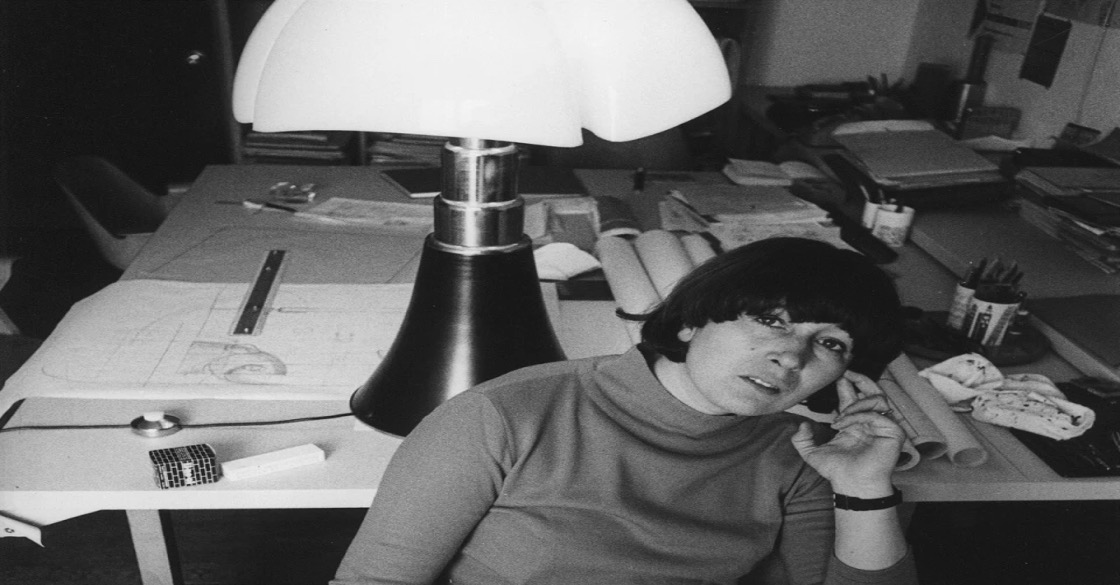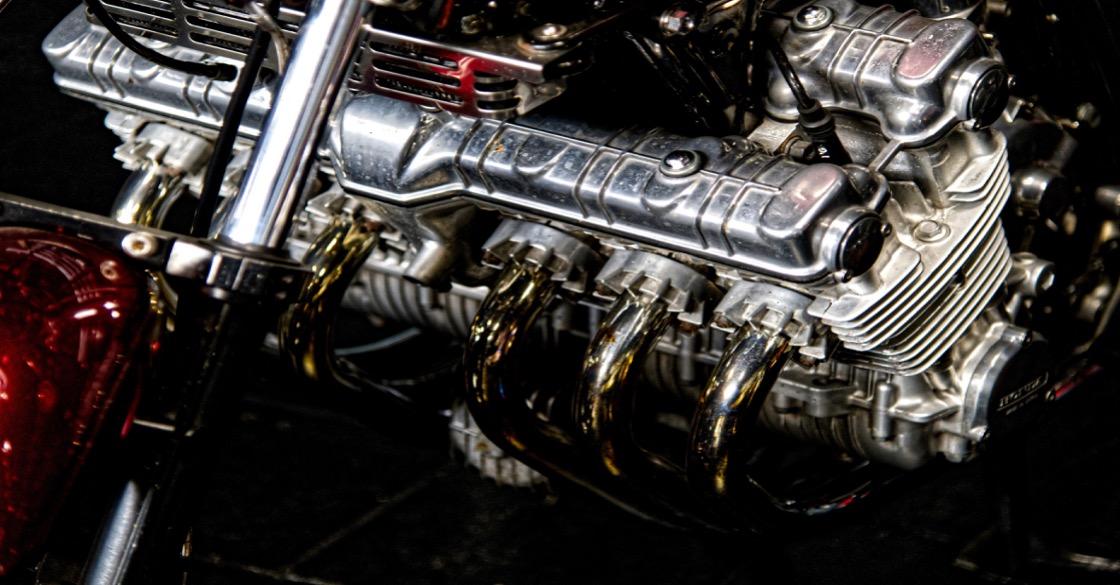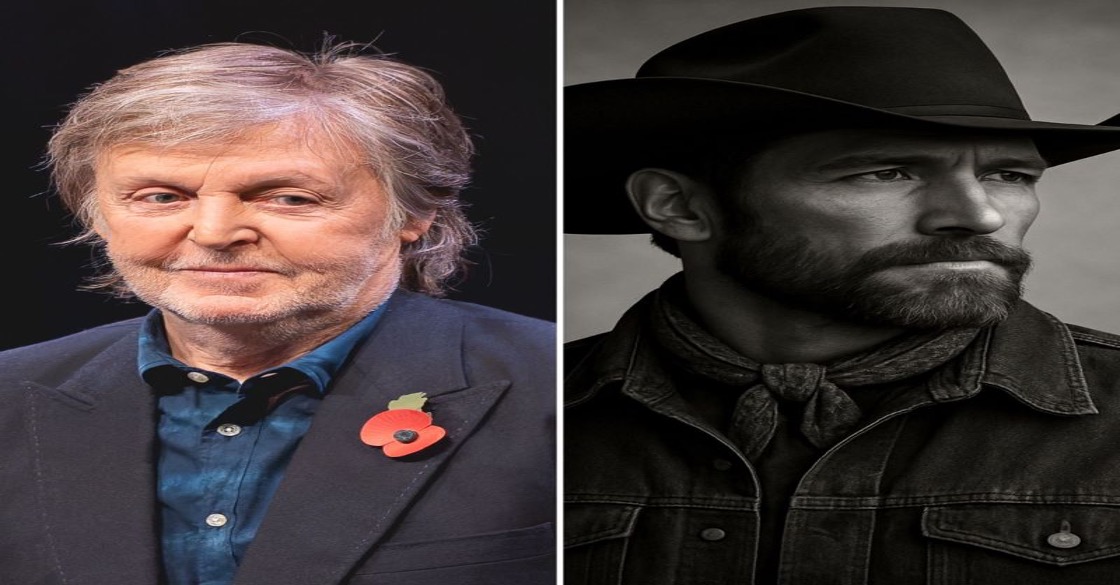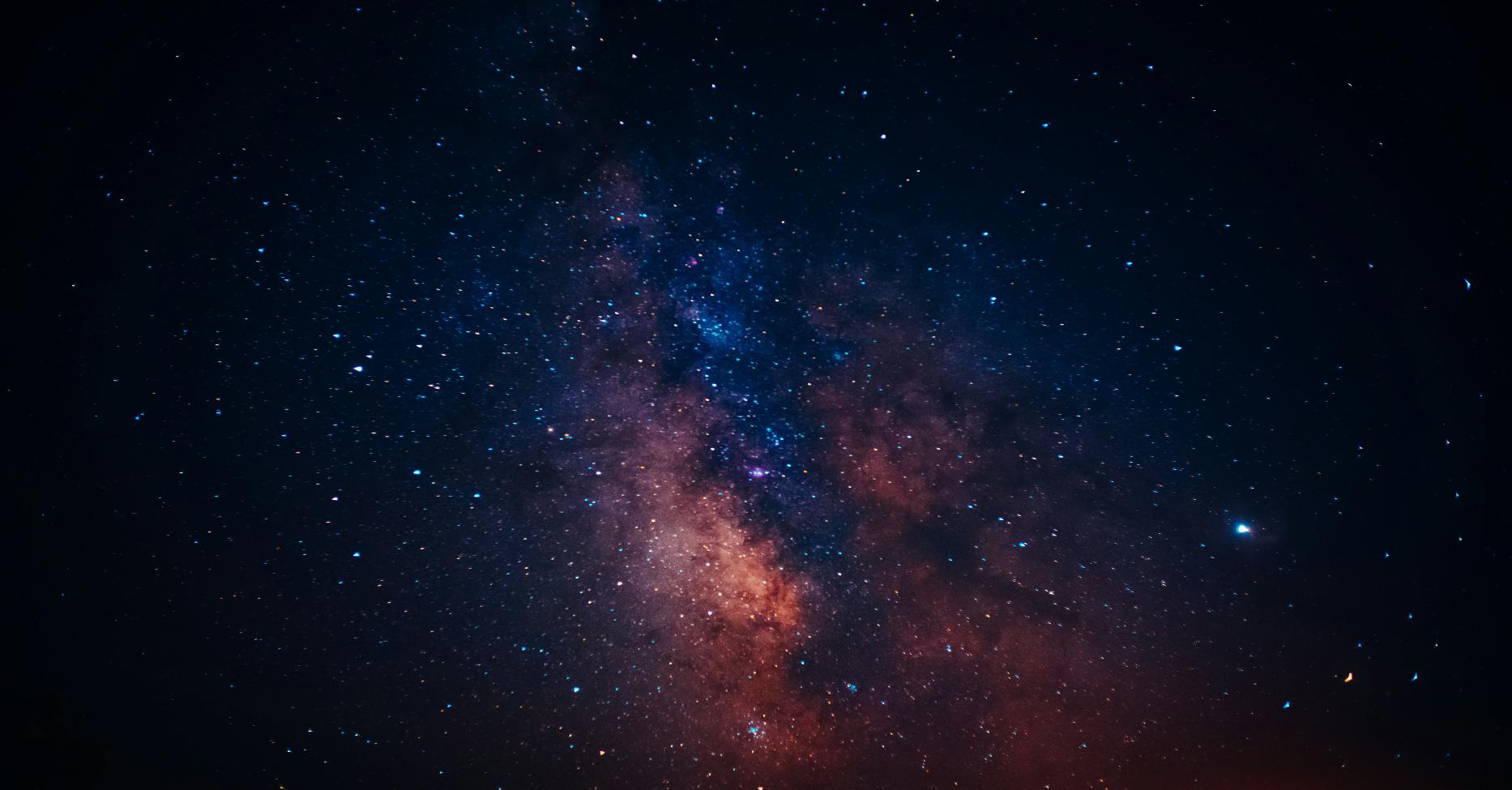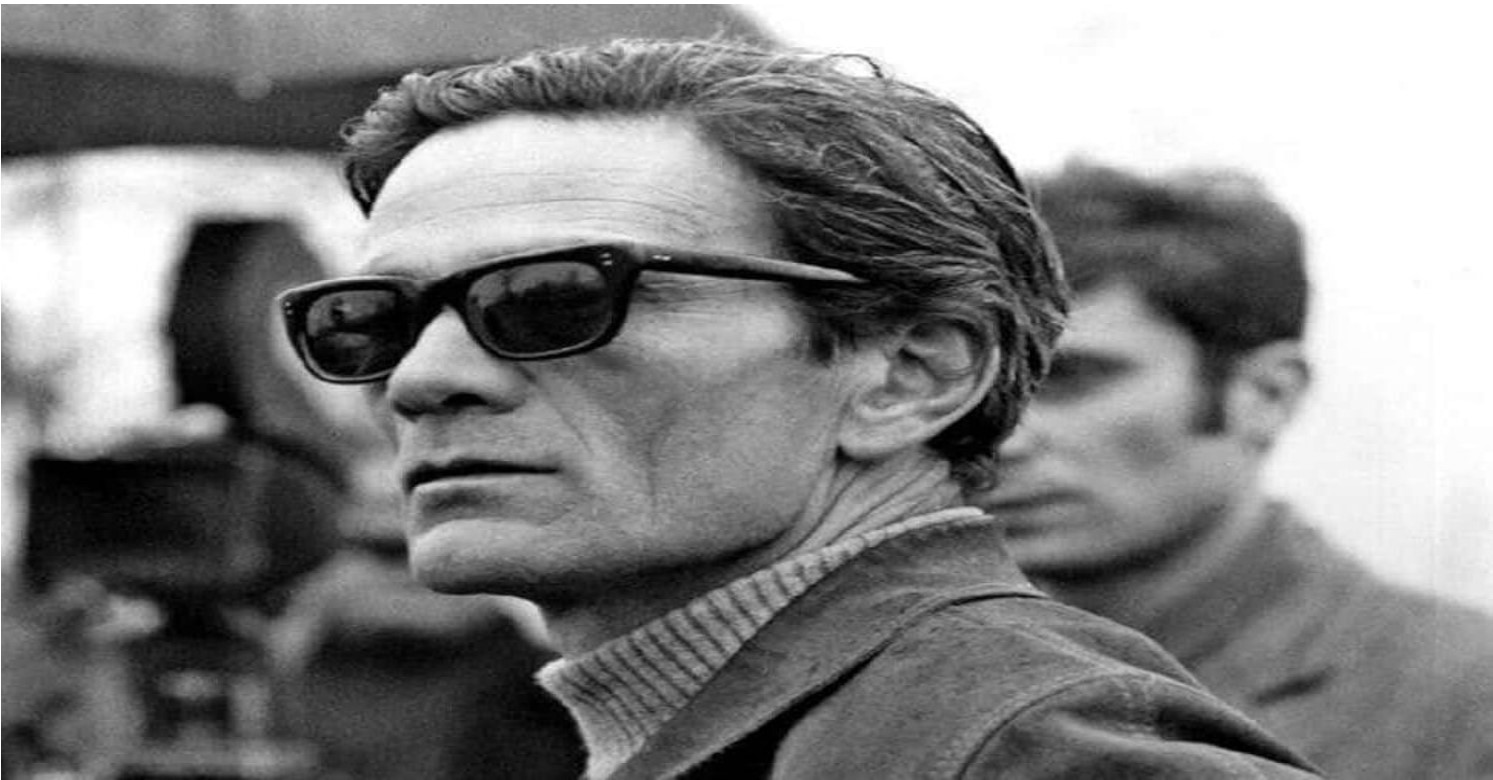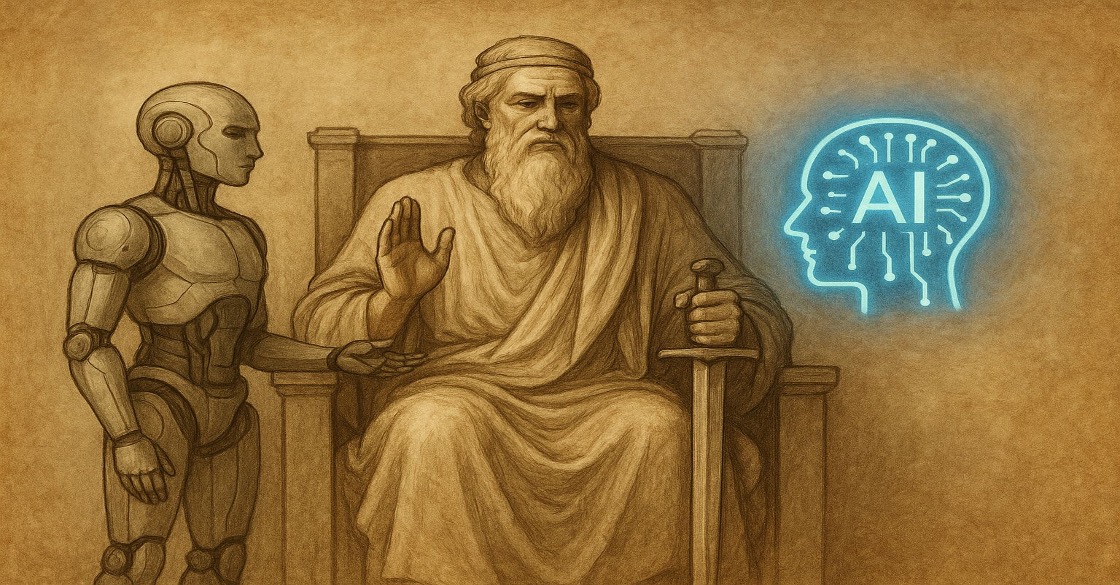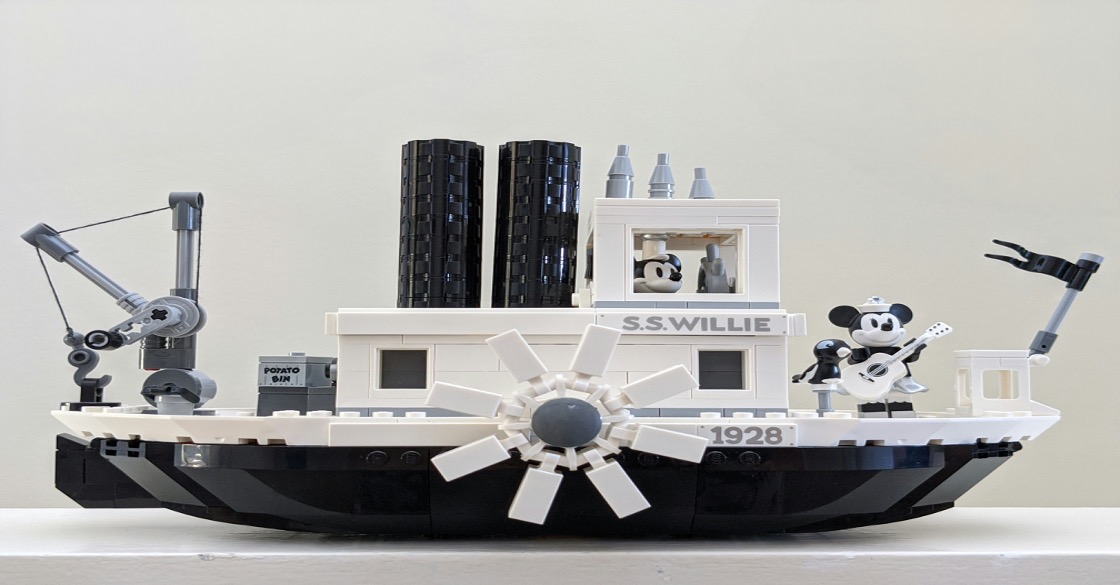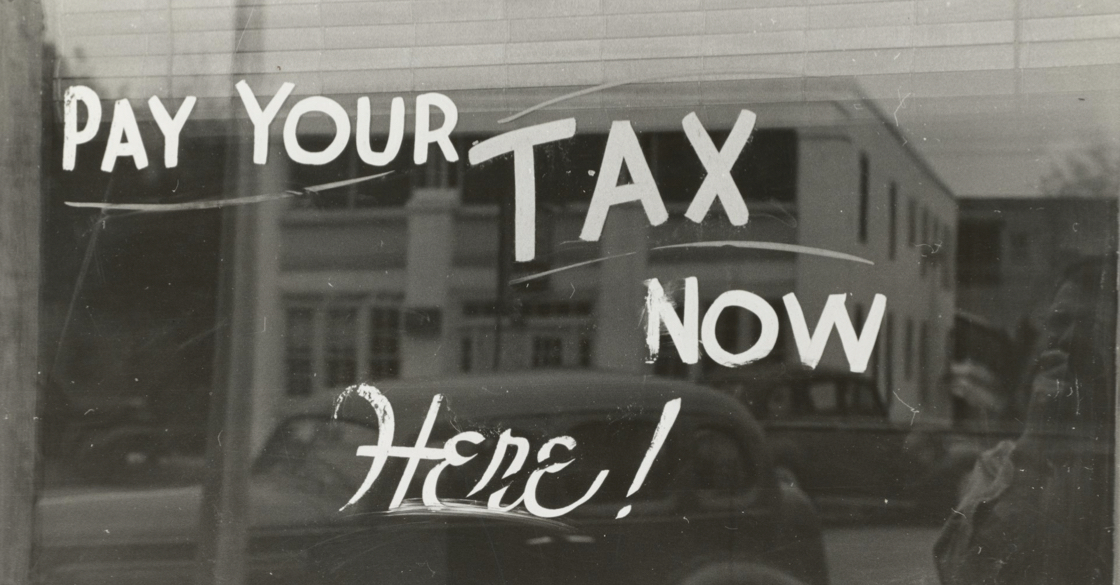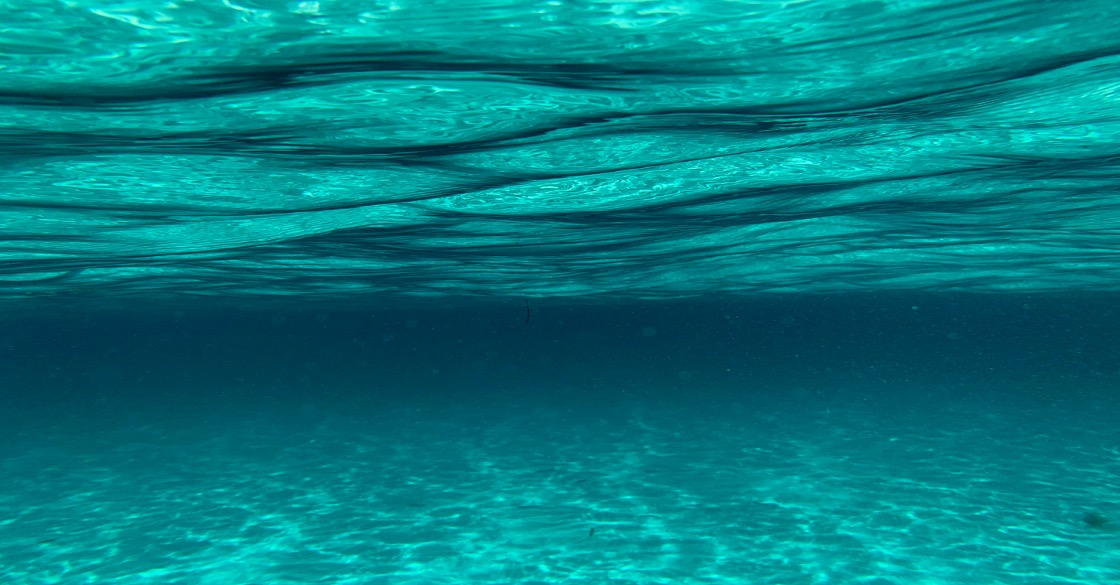Litigation funding: a che punto siamo?

Il third party litigation funding consente a un soggetto terzo di finanziare una causa in cambio di una parte dell’eventuale successo. Recenti pronunce della Cassazione (n. 4427/2024 e n. 13794/2024) hanno escluso che tale attività configuri un finanziamento regolato dall’art. 106 TUB, se priva di anticipazioni.
Sempre più spesso, anche in Italia, si sente parlare di litigation funding o, più precisamente, di third party litigation funding. Si tratta di un contratto atipico, di origine anglosassone, definito come quell’accordo mediante il quale un soggetto terzo rispetto ad una controversia (il finanziatore o Funder) si obbliga a sostenere gli oneri che graverebbero su una delle parti (la parte finanziata o Client) per intraprendere e coltivare la controversia medesima, facendosi carico delle spese eventualmente dovute alla controparte vittoriosa, in applicazione del principio della soccombenza. Corrispettivamente, la parte finanziata si impegna, per l’ipotesi di accoglimento della propria pretesa, a riconoscere al finanziatore una percentuale del credito accertato ovvero una somma stabilita nella misura e secondo le modalità preventivamente concordate tra le parti.
In buona sostanza, il finanziatore effettua un investimento sulla controversia, assumendosi il rischio della soccombenza della parte finanziata mentre il soggetto finanziato si garantisce i mezzi finanziari per sostenere gli oneri del contenzioso, riconoscendo al finanziatore una parte del risultato atteso dalla positiva conclusione dello stesso contenzioso.
Sino ad oggi, nel nostro paese si è assistito ad un “timido” sviluppo di tale strumento, per varie ragioni: da un lato, gli stringenti requisiti che i soggetti finanziatori applicano per la selezione delle controversie finanziare; dall’altro, l’assenza di qualsiasi riferimento giuridico che potesse aiutare ad identificare lo strumento di finanziamento del contenzioso. Rispetto a tale ultimo punto, appaiono rilevanti alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione che potrebbero segnare una svolta importante nell’utilizzo e conseguente sviluppo di tale strumento anche nel nostro sistema giuridico. In particolare, con ordinanza del 20 febbraio 2024, n. 4427, la Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi su un’azione di risarcimento danni avviata da un litigation funder in qualità di cessionario del credito risarcitorio nei confronti di alcune compagnie aeree per danno patito dai passeggeri a seguito di ritardi e cancellazioni dei voli – ha affermato il principio secondo il quale la cessione del credito che avviene tra il soggetto finanziato ed il soggetto finanziatore della controversia non è riconducibile ad una erogazione di finanziamento, in quanto il versamento del corrispettivo della cessione è solo eventuale poiché legato al buon esito della riscossione del credito ceduto. Per tale ragione, il credito può essere ceduto anche a soggetto non iscritto nell’apposito albo degli intermediari finanziari tenuto presso la Banca d’Italia.
Ancora, con il decreto n. 13794 del 17 maggio 2024, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento soggetta alla disciplina di cui all’art. 106 TUB è necessario che la cessione integri l’erogazione di un finanziamento e, quindi, che comporti l’anticipazione di denaro o altra utilità.
In ragione delle richiamate pronunce e in assenza di una specifica normativa al riguardo, si può concludere che l’attività tipica dei litigation funder sembrerebbe poter essere legittimamente svolta, senza iscrizione nell’apposito albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, laddove non vi sia il versamento di alcuna anticipazione finanziaria in favore del cedente.
Quanto alla posizione del client o soggetto finanziato, il ricorso al finanziamento della lite potrebbe rappresentare un valido strumento per esternalizzare la gestione delle controversie ed i relativi costi.
Scarica qui l’articolo completo in PDF.