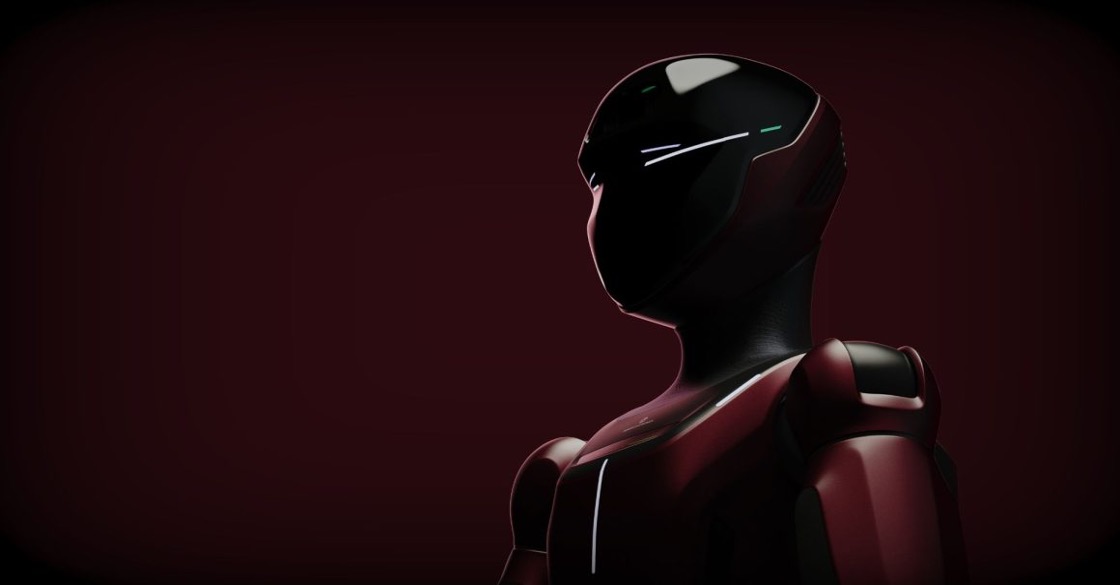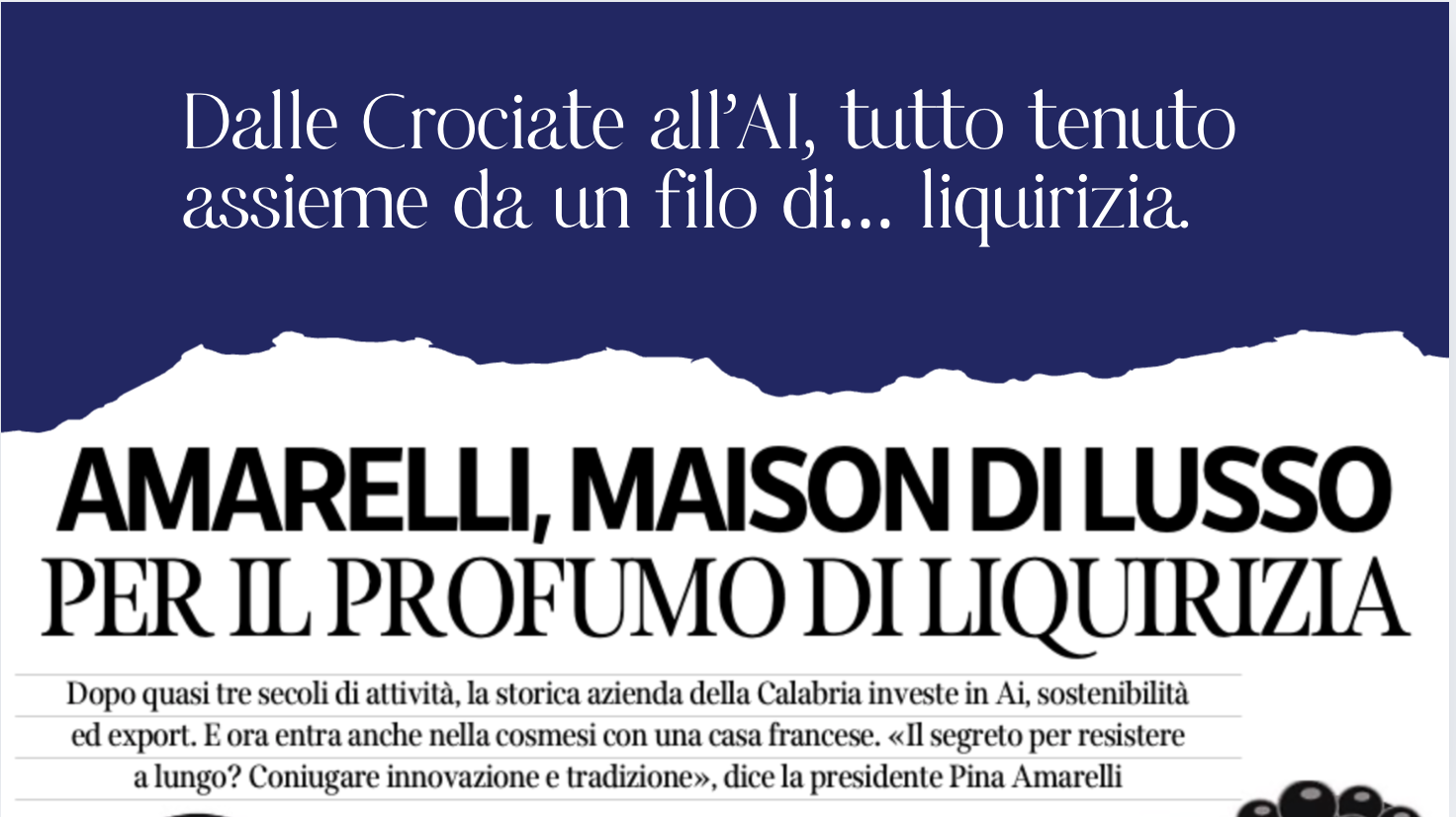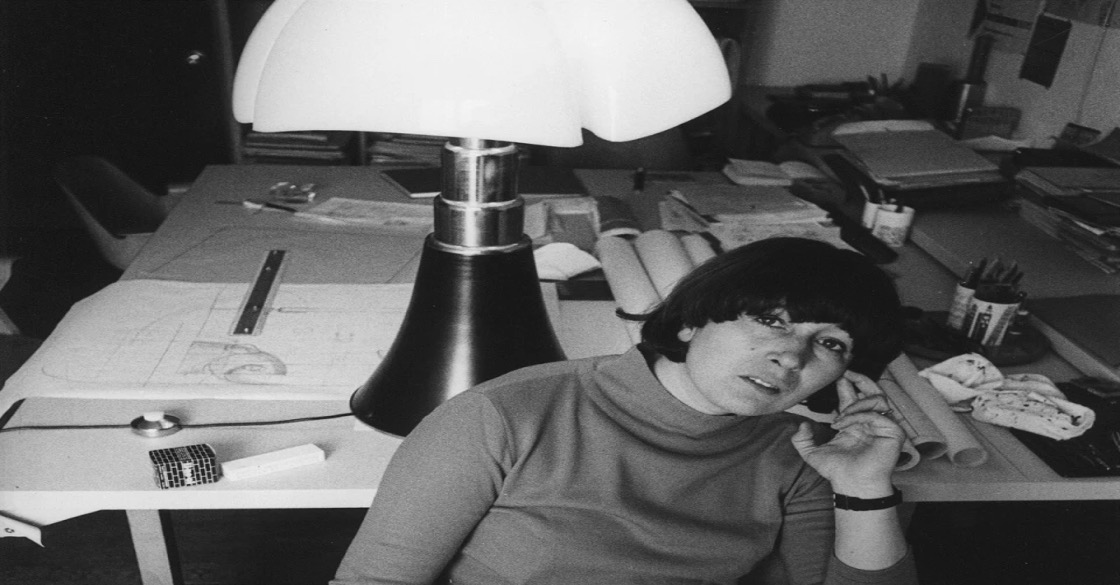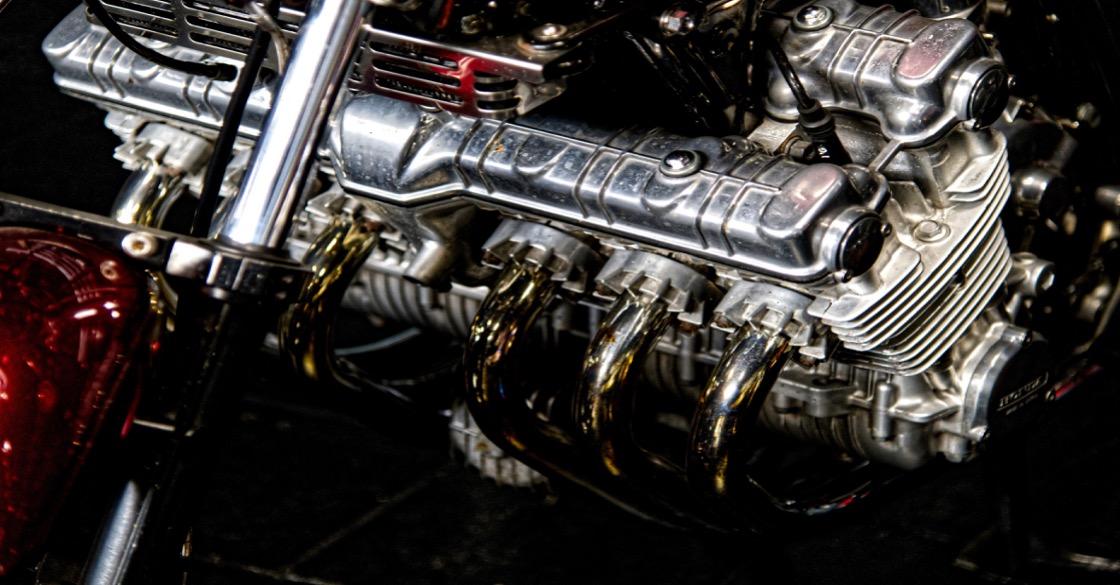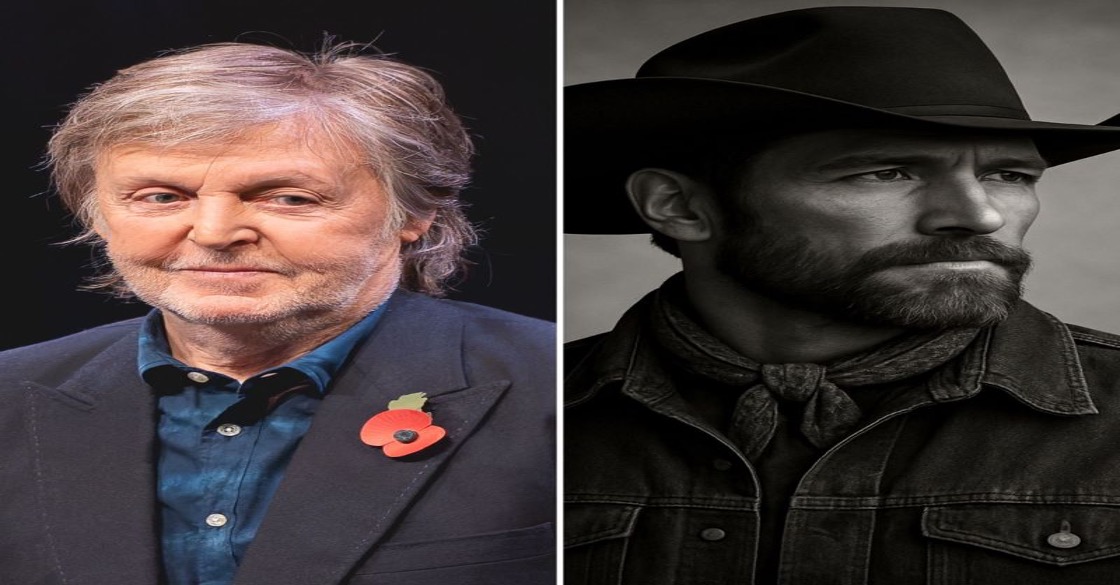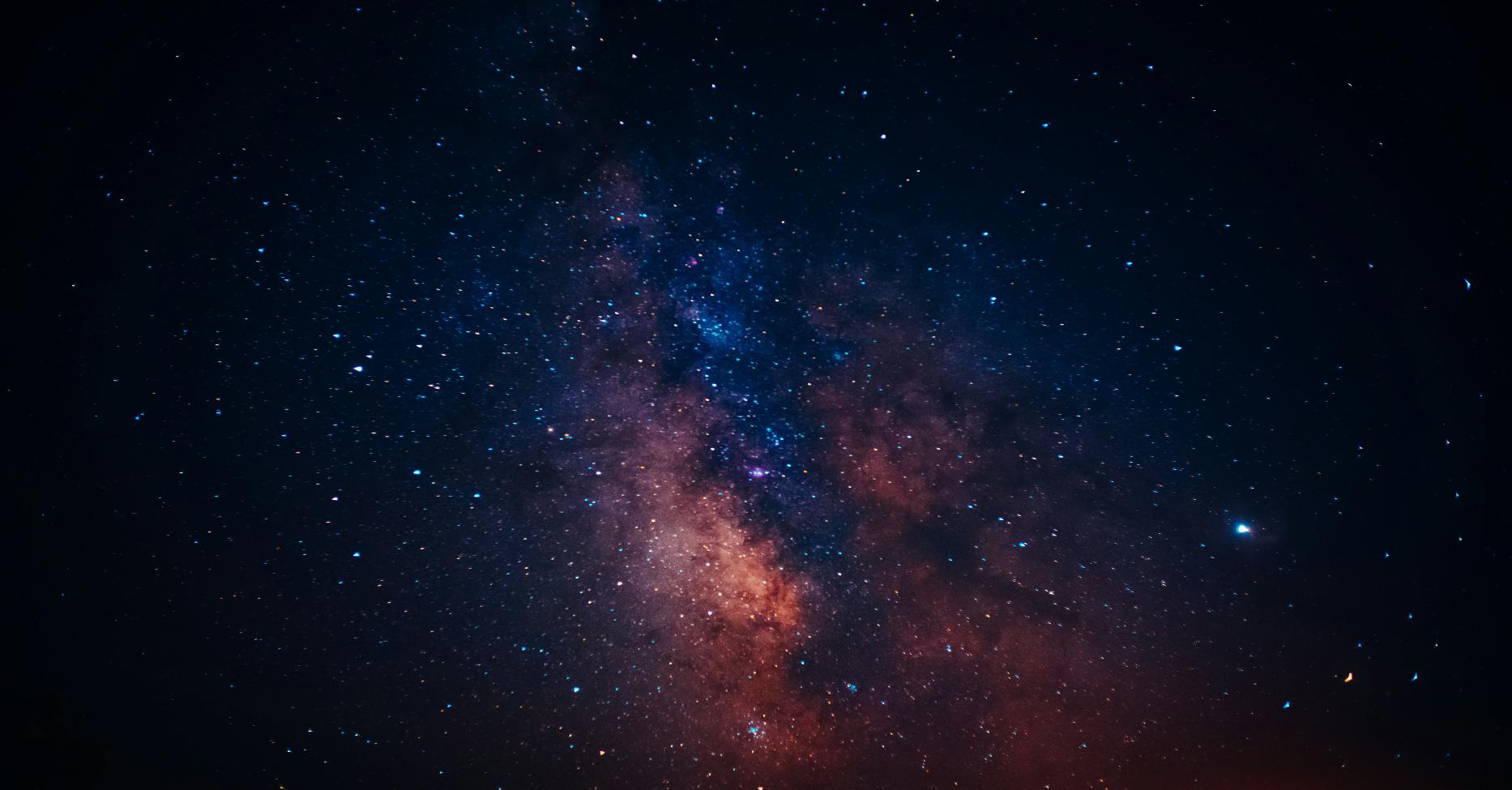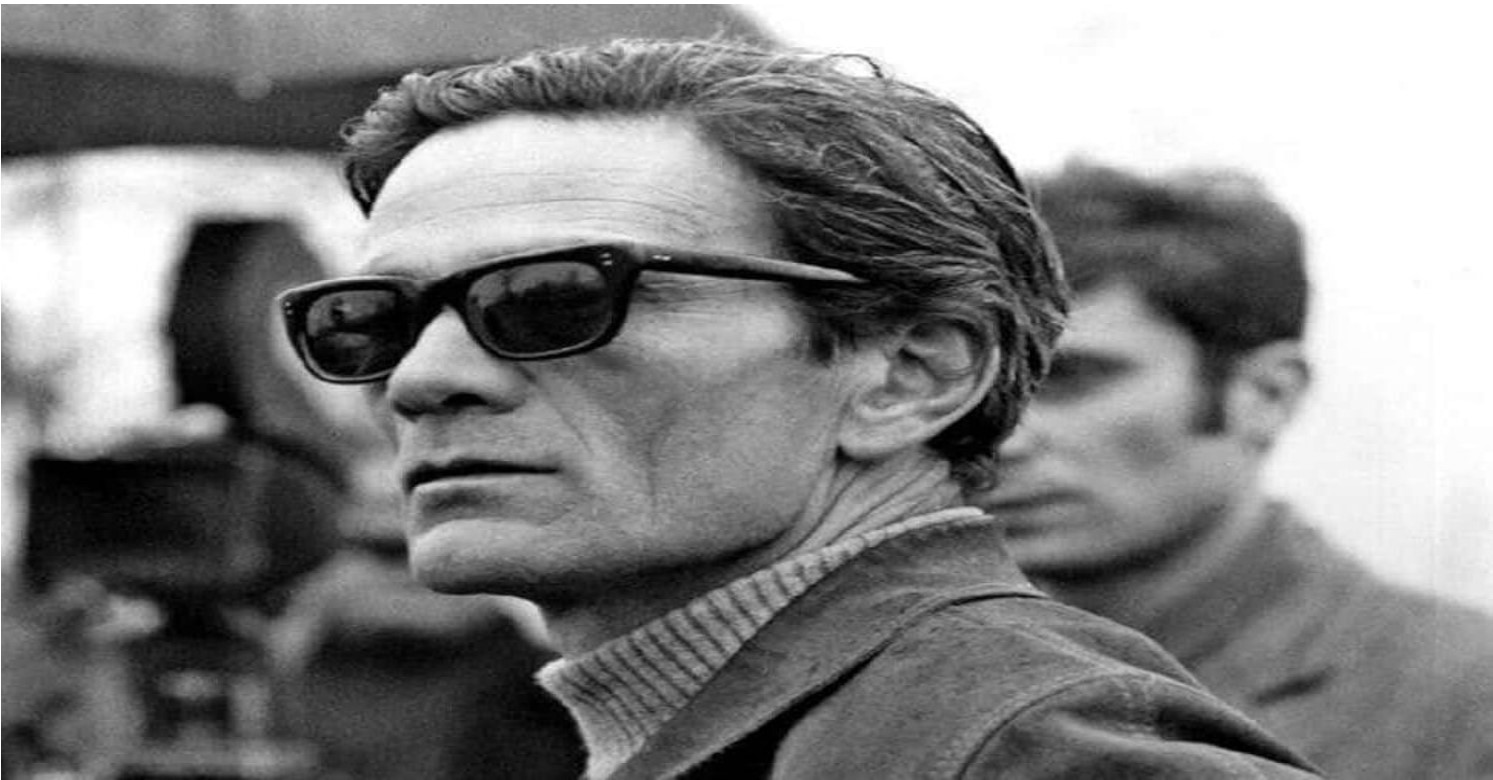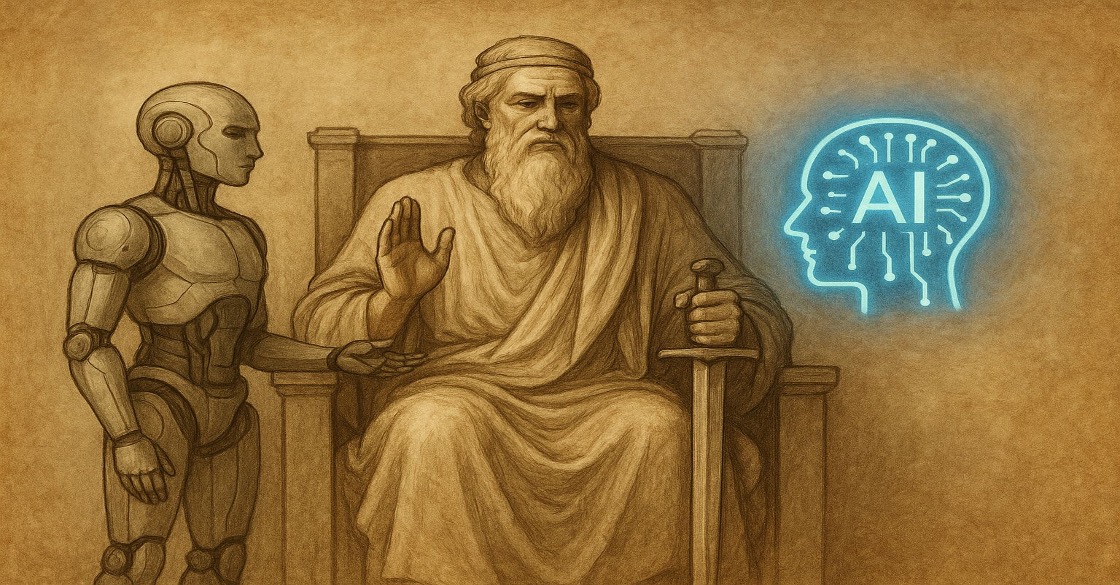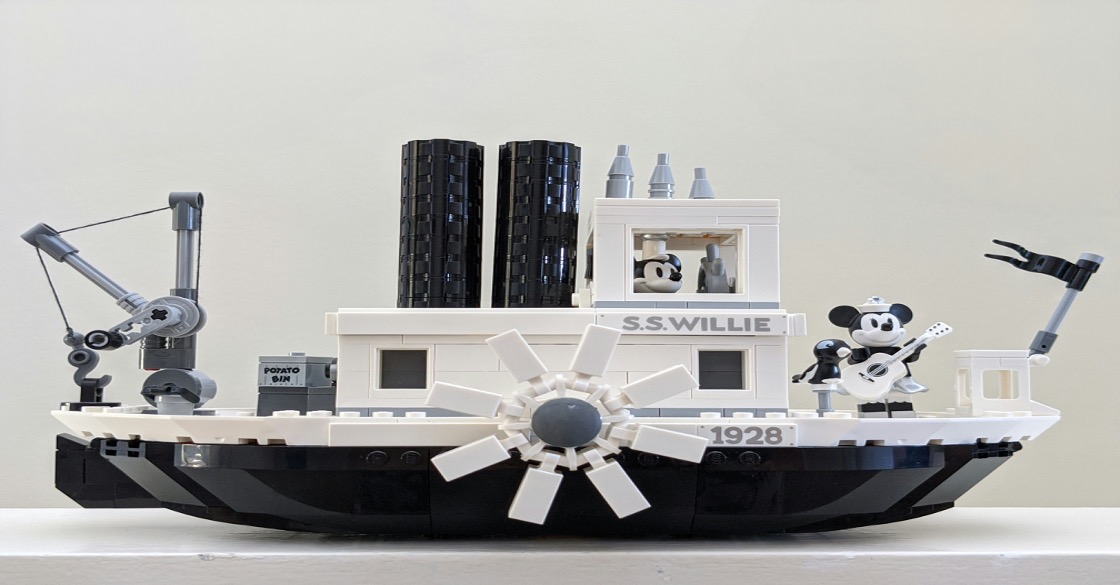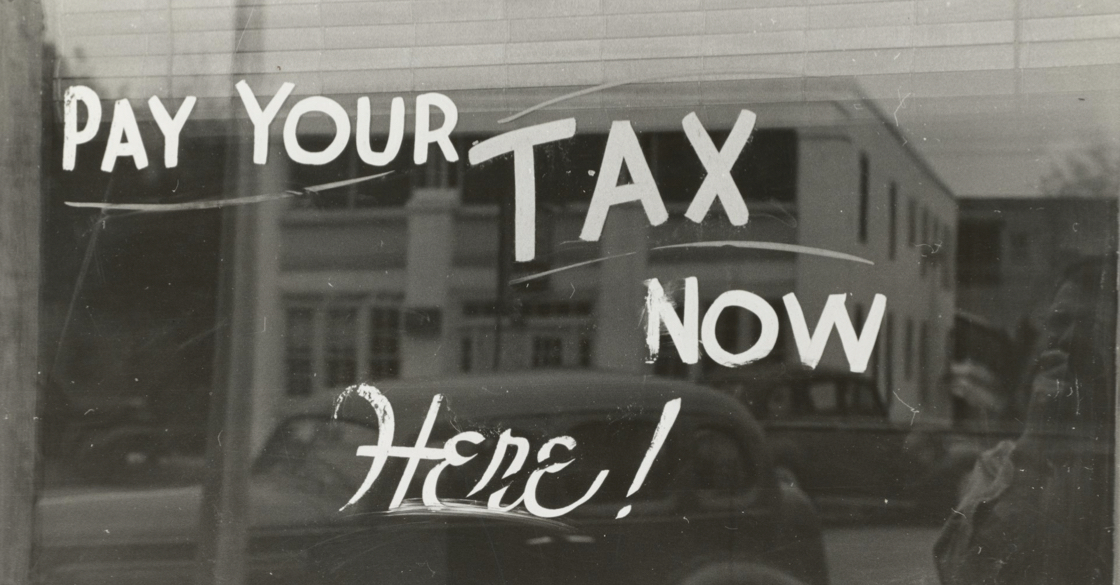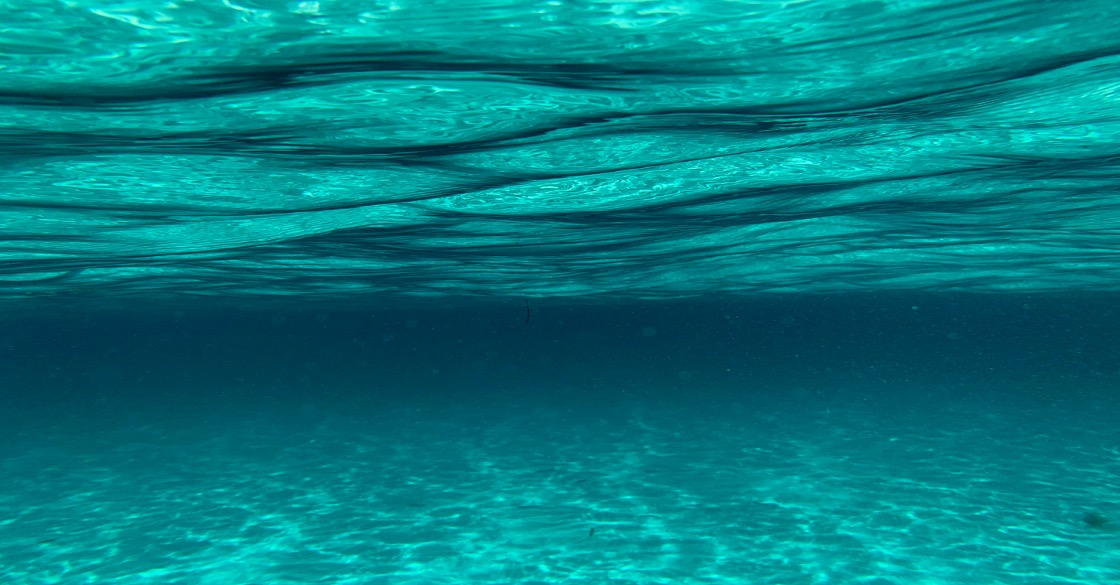L’utilizzo di check list come strumento per superare l’ostacolo della prova contraria in tema di I.C.A

Le I.C.A. sono un grave problema sanitario e legale, con alti tassi di incidenza e mortalità in Italia. La Cassazione (sent. n. 6386/2023) ha escluso la responsabilità oggettiva delle strutture sanitarie, richiedendo la prova di adeguate misure preventive. Ciò sposta l’approccio verso una responsabilità attiva, basata su gestione del rischio, protocolli documentati e formazione del personale.
Come noto con l’acronimo I.C.A. si indicano le infezioni correlate all’assistenza, ovvero: si fa riferimento, in particolare, a tutte le infezioni che siano in vario modo causate dalla presenza di microrganismi patogeni opportunisti in ambiente nosocomiale e che siano insorte nel corso di un ricovero.
Dati relativi alle I.C.A. in Europa e in Italia.
Secondo i dati del primo Rapporto Globale dell’OMS (maggio 2022) le I.C.A. hanno un impatto clinico ed economico rilevante in termini di maggiore mortalità, maggior durata della degenza, disabilità a lungo termine, aumento della resistenza dei microrganismi agli antibiotici e un carico economico ulteriore per i sistemi sanitari, i pazienti e le loro famiglie.
Dalle ultime stime disponibili, 7 pazienti su 100 ricoverati negli ospedali dei Paesi ad alto reddito (15 su 100 nei Paesi in via di sviluppo) contraggono almeno un’infezione durante il ricovero e 1 su 10 muore a causa dell’infezione contratta. In Europa ogni anno le I.C.A. causano 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi direttamente attribuibili e 110.000 decessi in cui l’infezione è una concausa. Solo per la quota dei costi diretti si stimano circa 7 miliardi di euro di impatto.
Nel contesto nazionale, un recente studio del Centre for Economic and International Studies dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sui dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) dell’ultimo decennio stima che la spesa totale per infezioni ospedaliere ammonti in Italia a 783 milioni di euro.
Secondo il rapporto pubblicato dall’ “European Center for disease prevention and control” (ECDC), nel 2022-2023, in Italia, circa 430 mila persone ricoverate hanno contratto un’infezione ospedaliera (8,2%), un dato superiore alla media UE (6,5%). L’Italia ha fatto registrare il secondo peggior risultato del continente dopo il Portogallo (8,9%). Nel rapporto sopra richiamato, la direttrice dell’ECDC ha affermato che: “Le infezioni associate all’assistenza sanitaria rappresentano una sfida significativa per la sicurezza dei pazienti negli ospedali di tutta Europa. Questi numeri recenti evidenziano l’urgente necessità di ulteriori azioni per mitigare questa minaccia”.
Infine, sulla base di alcuni dati pubblicati dal Quotidiano Sanità, nel febbraio 2024 l’Italia ha avuto la maglia nera in Europa per le morti connesse alle Infezioni Correlate all’Assistenza provocate da germi multiresistenti agli antibiotici: ogni anno, nel nostro Paese, si contano 11 mila morti, un terzo di tutti i decessi.
I riflessi giuridici delle I.C.A. in tema di responsabilità delle strutture sanitarie.
Tra gli obblighi delle strutture ospedaliere nei confronti dei pazienti vi è quello di garantire l’asepsi degli ambienti e degli strumenti utilizzati.
Si può ritenere che, fino a pochi anni fa, la responsabilità addebitata alle strutture ospedaliere presso le quali si verificava un evento avverso collegato ad una I.C.A. veniva determinata in termini di responsabilità oggettiva, sulla base del seguente ragionamento logico-giuridico:
- L’ospedale deve essere un luogo asettico;
- Il paziente ha contratto l’infezione in ospedale quindi l’asepsi non fu garantita;
- Non aver garantito l’asepsi è colpa del personale sanitario e, quindi, dell’ente sanitario.
Nella prassi giudiziaria, seppure la struttura fosse riuscita a dimostrare di aver provveduto alla puntuale sanificazione degli ambienti e degli strumenti attraverso l’adozione di regolamenti e protocolli ad hoc, all’esito dell’accertamento giuridico sarebbe stata pronunciata, comunque, una sentenza di condanna nei confronti dell’ente poiché, essendosi l’infezione verificata in ospedale, era ragionevole presumere – secondo la regola del più probabile che non – che la disinfezione non era stata svolta correttamente, ovvero non erano state, correttamente, attuate dal personale sanitario tutte le regole ed i protocolli adottati a tal fine dalla struttura.
In ragione di ciò, a carico della struttura si è imposta una vera e propria probatio diabolica.
Con una importante sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 03/03/2023, n. 6386 sono stati, però, stabiliti una serie di principi che potrebbero dare nuovi spunti ai risk managers delle strutture sanitarie e ai loro legali per una più corretta gestione correlata alla prevenzione del rischio legato al verificarsi di eventi avversi causati da I.C.A. o del contenzioso avviato per ottenere il risarcimento dei danni subiti per tale circostanza.
Riportiamo, di seguito, alcuni rilevanti precetti contenuti nella sentenza sopra richiamata in virtù della quale i Giudici della Cassazione hanno tentato di stilare un vero e proprio decalogo rivolto alle strutture sanitarie:
- in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell’indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento; g) dell’avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell’orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
- La fattispecie delle infezioni nosocomiali non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva, rilevando, ai fini dell’affermazione di responsabilità della struttura sanitaria, il criterio temporale (e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale), il criterio topografico (i.e. l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento) e il criterio clinico (ogni volta che, in ragione della specificità dell’infezione, sia possibile verificare quali misure di prevenzione era necessario adottare).
- In tema di infezioni nosocomiali, per andare esente da responsabilità, sotto il profilo soggettivo, il dirigente apicale è tenuto a dimostrare di avere indicato le regole cautelari da adottarsi, in attuazione del proprio potere-dovere di sorveglianza e verifica; il direttore sanitario di averle attuate e avere organizzato gli aspetti igienico e tecnico sanitari, vigilando altresì sull’attuazione delle indicazioni fornite; il dirigente di struttura complessa, esecutore finale dei protocolli e delle linee-guida, di avere collaborato con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo e igienista, essendo tenuto ad assumere precise informazioni sulle iniziative degli altri medici ovvero a denunciare le eventuali carenze della struttura, ed è responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili.
- In tema di infezioni nosocomiali, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra l’infezione e la degenza ospedaliera, al CTU deve essere demandata, tra l’altro, la verifica della mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione e del mancato rispetto delle stesse, nonché dell’omessa informazione circa la possibile inadeguatezza della struttura per l’indisponibilità di strumenti essenziali e della eventuale effettuazione di un ricovero non sorretto da alcuna esigenza di diagnosi e cura ed associato ad un trattamento non appropriato.
- In tema di responsabilità sanitaria in conseguenza di infezione nosocomiale, la valutazione della causalità materiale deve essere effettuata sulla base di un giudizio di probabilità logica o del “più probabile che non”, secondo i criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti) e clinico, in ragione del quale, a seconda della specificità dell’infezione, dev’essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria (nella specie, è stata annullata la sentenza di secondo grado, che, pur ritenuta provata la contrazione di una infezione nosocomiale, aveva negato che un trattamento immediato con terapia antibiotica potesse comportare la certezza della guarigione della paziente, così escludendo il nesso di causa).
Prospettive future.
Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza sopra richiamata, se da un lato può considerarsi impegnativa, per la struttura sanitaria, l’attività prodromica alla difesa in giudizio e finalizzata al raggiungimento della prova liberatoria; dall’altro, la pronuncia in rassegna diviene, per la struttura stessa, i risk managers e tutti i vertici aziendali, una “guida” da seguire per (tentare) di rendere effettivo il diritto di difesa nei casi di medical malpractice che abbiano ad oggetto l’accertamento di danni subiti a causa delle I.C.A.
Ma non solo.
Esaminando la pronuncia richiamata sotto un diverso profilo si potrebbe concludere affermando che si sta assistendo ad uno spostamento del baricentro della responsabilità della struttura sanitaria oggi orientato sulle regole della “responsabilità attiva” – più che sulla colpevolizzazione dell’ente –, secondo la logica del Clinical Risk Management per cui l’obiettivo prioritario, in base a un approccio proattivo e organizzativo, deve essere la minimizzazione degli errori e degli eventi avversi.
Ed è in quest’ottica che la previsione e la redazione di vere e proprie check list da far compilare al personale sanitario per dare prova delle regole di prevenzione delle I.C.A. attuate, ad esempio in sede di intervento chirurgico prima, durante e dopo l’intervento stesso, ovvero l’organizzazione di corsi di formazione ad hoc per il personale sanitario, potrebbero diventare delle buone prassi da introdurre all’interno dell’organizzazione della struttura.
Scarica qui l’articolo completo in PDF