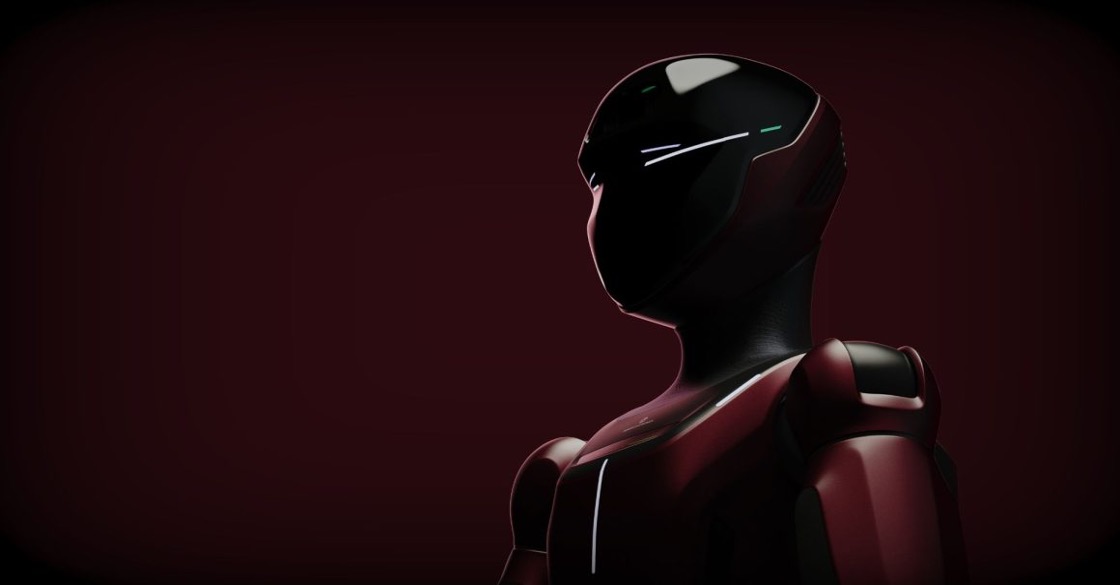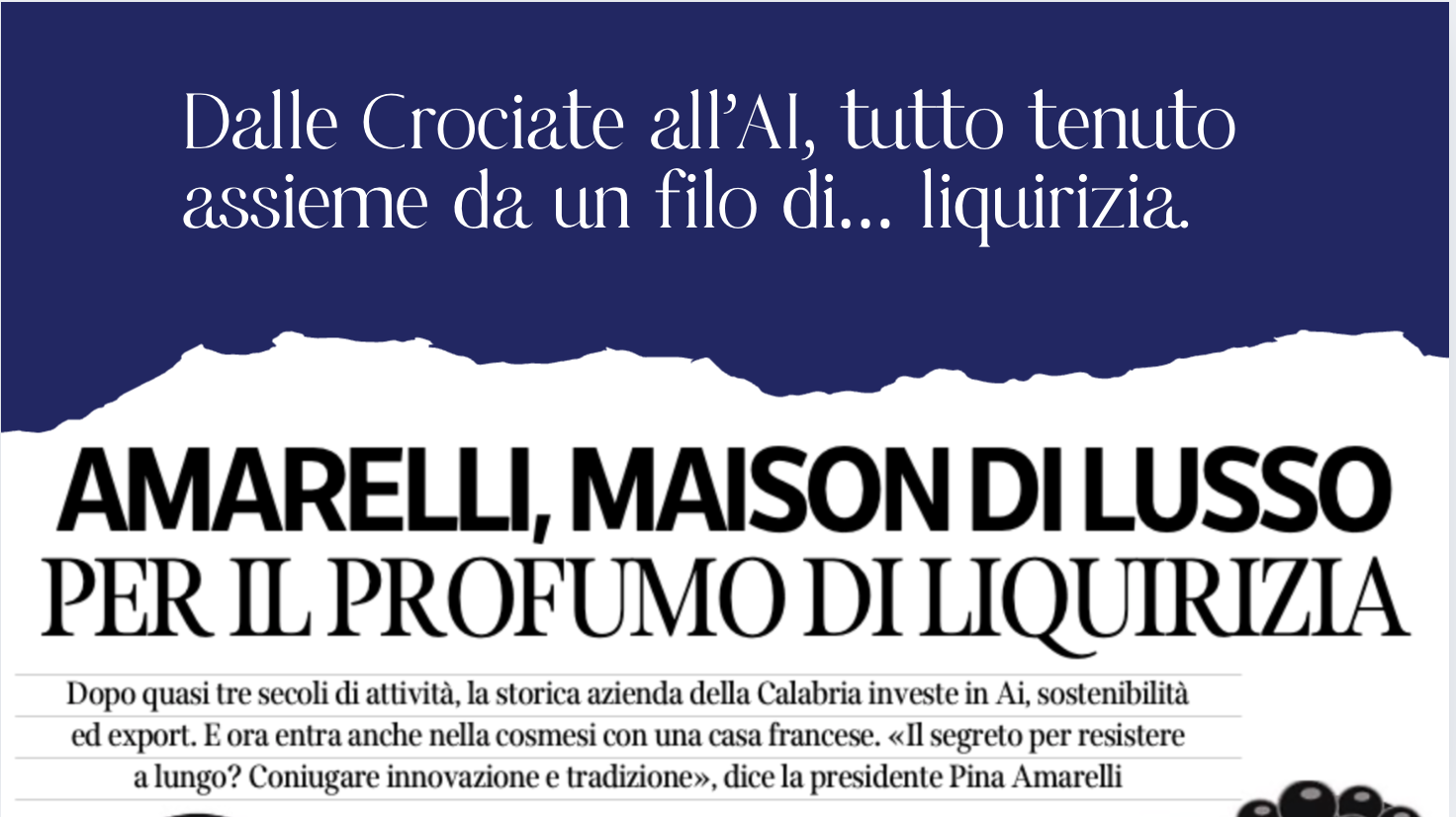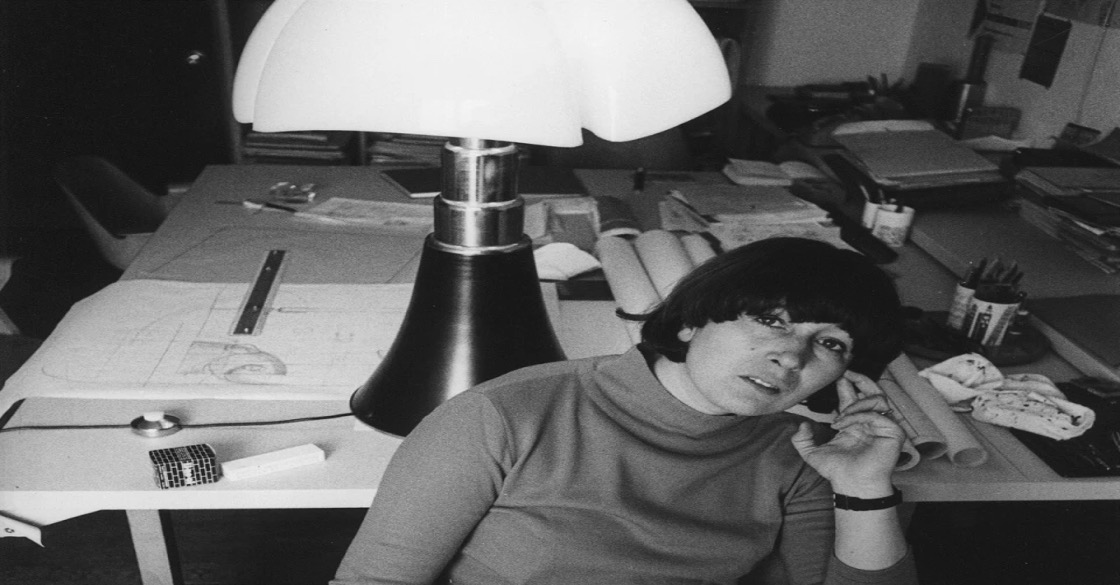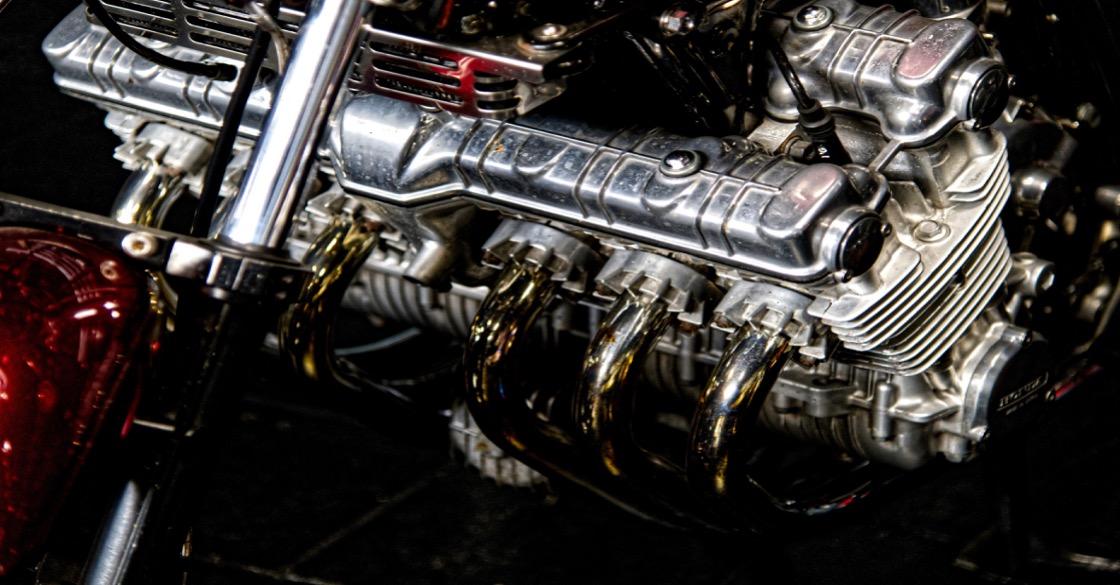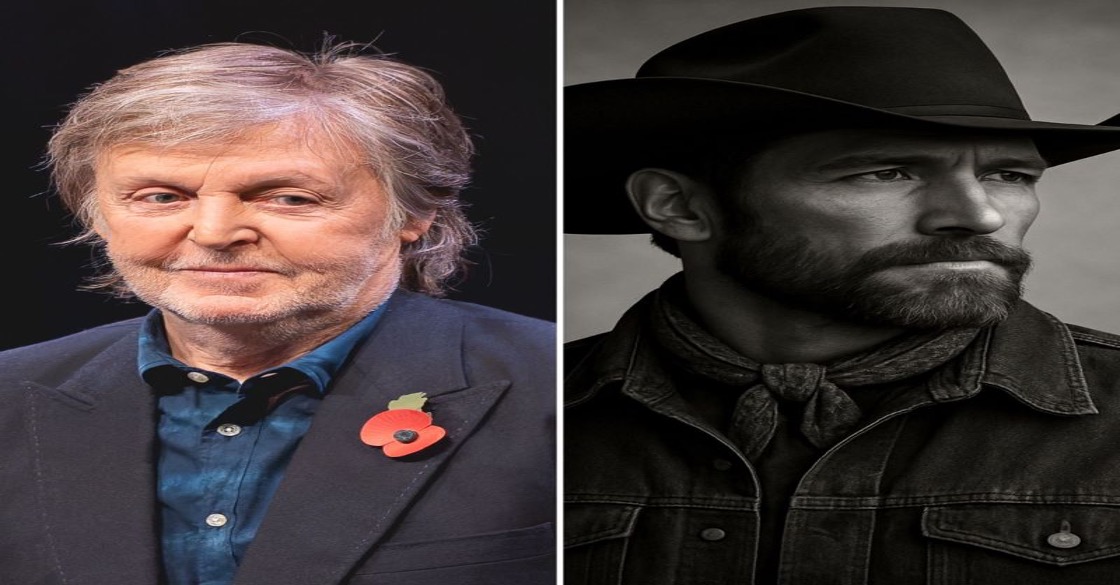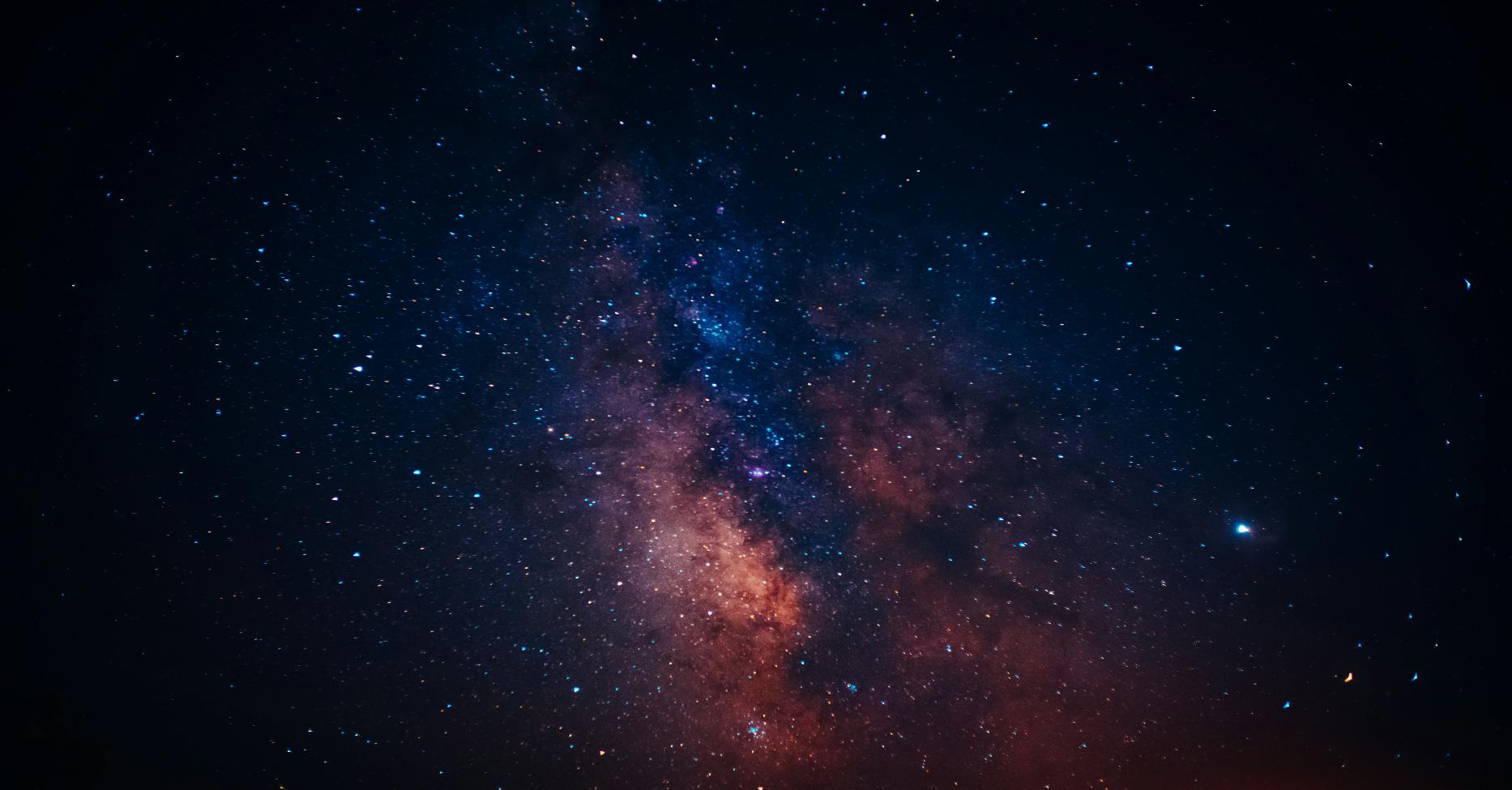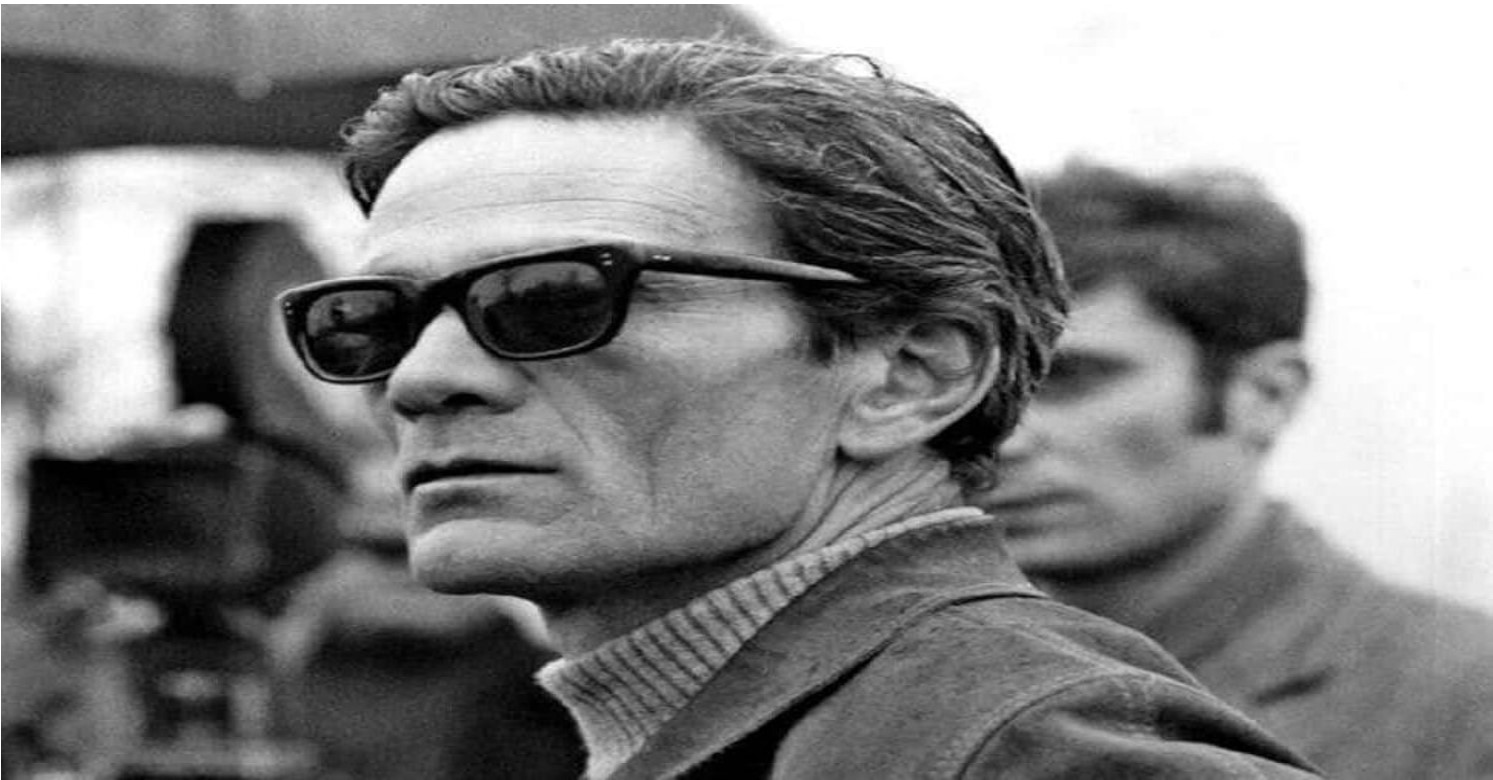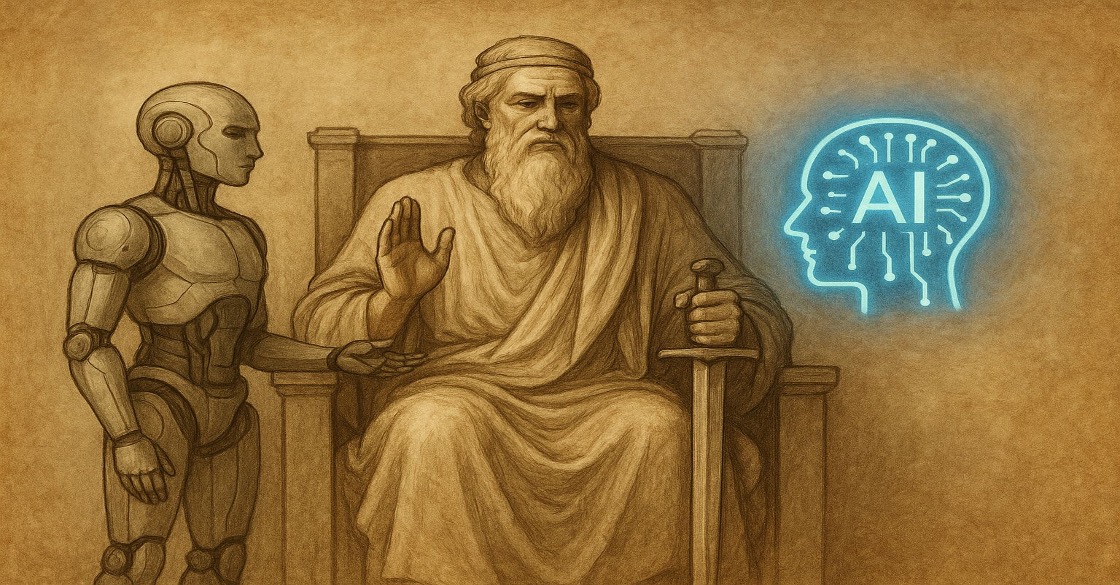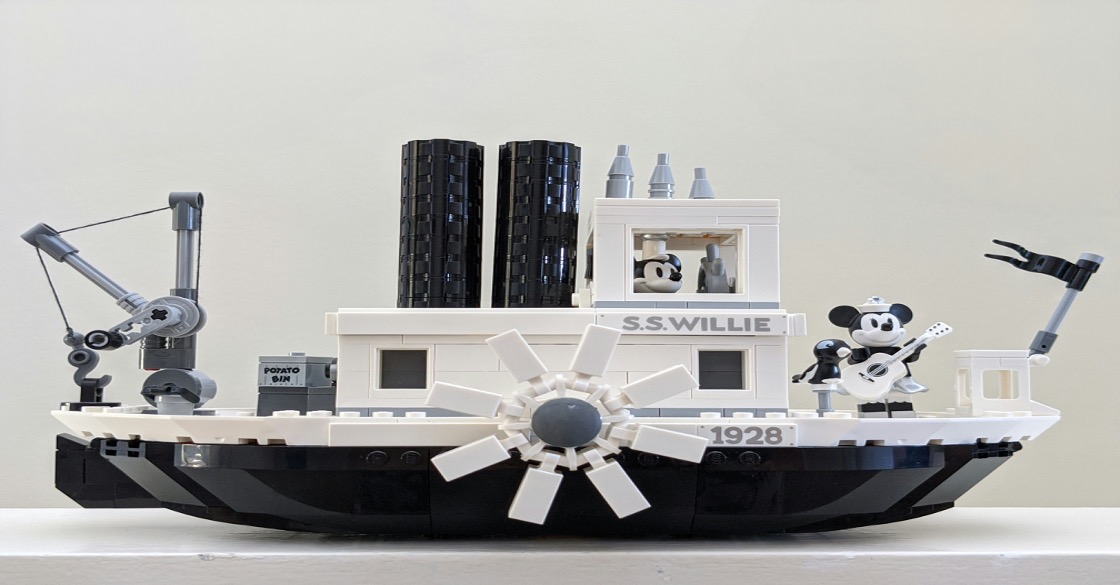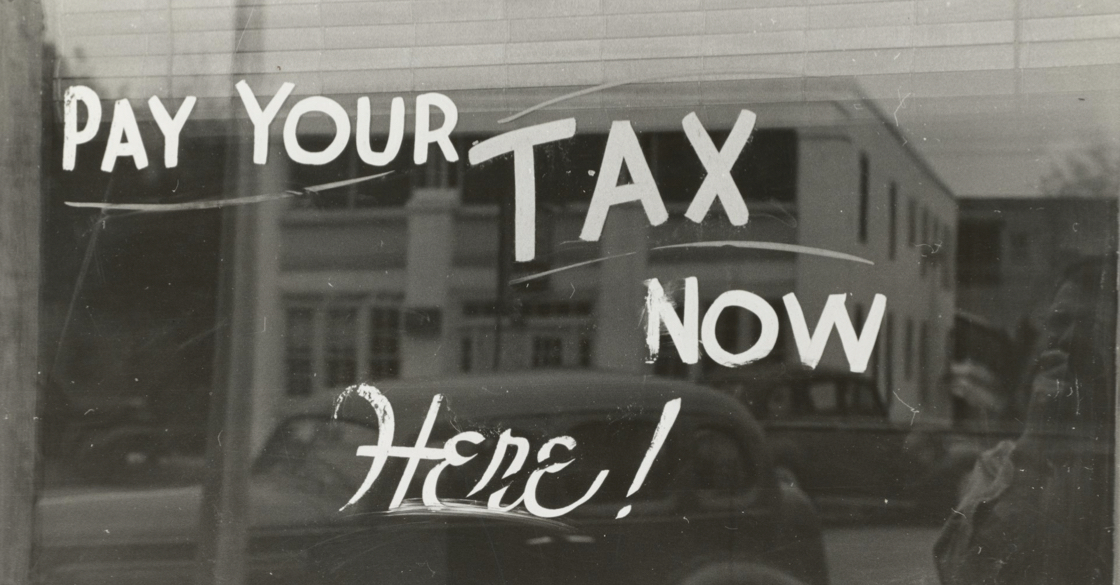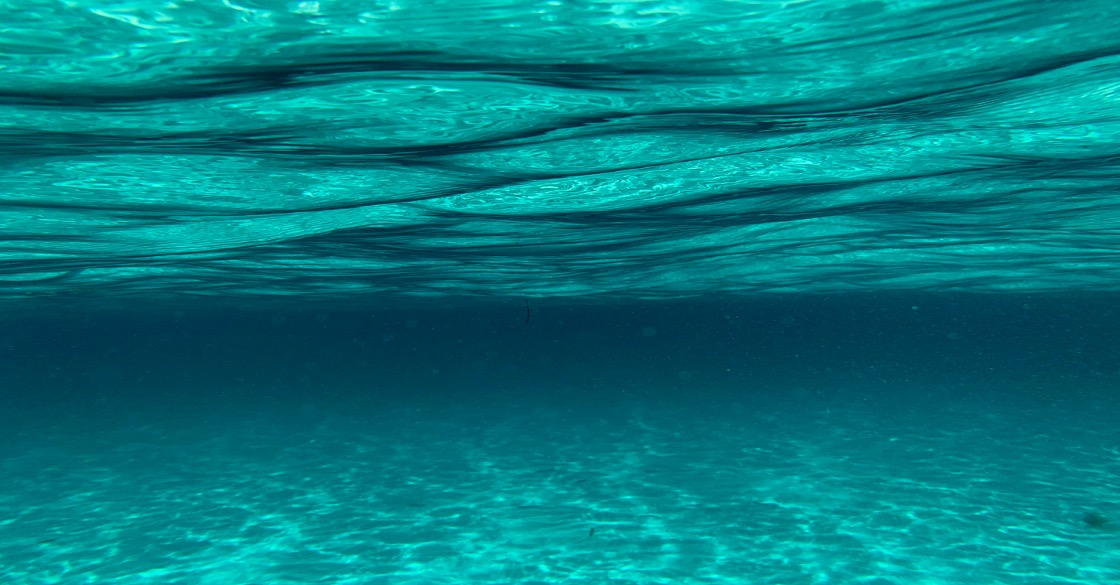Il ricorso alla rendita vitalizia quale forma di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2057

La Cassazione, con la sentenza n. 31574/2022, ha valorizzato l’art. 2057 c.c., legittimando il risarcimento del danno permanente tramite rendita vitalizia. Questa modalità comporta rilevanti impatti economici su assicurazioni e strutture sanitarie. Si auspica, quindi, un intervento legislativo per bilanciare equità risarcitoria e sostenibilità finanziaria
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione, in materia di risarcimento danno alla persona, ha rispolverato dettati normativi considerati ormai giacenti nell’oblio. In particolare, la sentenza n. 31574 del 25 ottobre 2022 ha richiamato l’attenzione del mondo giuridico e di quello assicurativo, su una norma di rara applicazione – esistente dall’emanazione del Codice civile del 1942: l’articolo 2057 .
Con la pronuncia sopra richiamata, la terza sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso di malpractice medica caratterizzato dalla ritardata diagnosi di una meningoencefalite grave in un paziente, minore di età, che ne era risultato affetto, causandogli gravi lesioni permanenti. Il giudice di prime cure, accertata la responsabilità della struttura sanitaria, l’ha condannata al risarcimento dei danni, liquidando gli stessi in capitale. In appello, la Corte, confermando la condanna dei convenuti al risarcimento, ne ha stabilito la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex. art. 2057 c.c., ritenendo tale soluzione meglio rispondente alle esigenze del danneggiato.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dai convenuti riguardo alla scelta del metodo liquidatorio ed alle relative misure adottate dalla Corte d’Appello, ha apprezzato l’innovazione della soluzione risarcitoria decisa dai giudici di secondo grado, stabilendo alcuni rilevanti principi in materia di risarcimento danni alla persona.
In estrema sintesi, i giudici della Cassazione hanno sostenuto la legittimità della decisione impugnata, chiarendo, innanzitutto, che il danno permanente è, ai sensi dell’art. 2057 c.c.,: “ […] il terreno di elezione per un risarcimento in forma di rendita, l’unico che consenta di considerare adeguatamente sotto molteplici aspetti, tra cui quello dell’effettività della tutela e della giustizia della decisione, l’evoluzione diacronica della malattia (ovvero la sua guarigione se possibile), così che l’antinomia tra l’astratta efficacia di tale strumento risarcitorio e la sua (mancata) applicazione in concreto appare segnata, in premessa, da una sorta di sostanziale quanto non giustificabile “diffidenza” nei suoi confronti”.
Gli ermellini hanno, poi, precisato che la liquidazione del risarcimento del danno permanente sotto forma di rendita è facoltà del giudice e non un diritto delle parti che possa esser avanzato con apposita istanza , affermando, altresì, che la rendita è “una forma privilegiata di risarcimento” che consente di cogliere appieno tutte le componenti del danno che il danneggiato avrebbe subito, “senza che ciò si risolva in un indebito vantaggio per il danneggiante, sia perché il risarcimento per equivalente del danno biologico permanente e del danno morale ad esso conseguente comporta il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti al danneggiato giorno per giorno e sino alla fine della sua vita, sia perché allo spirare dell’esistenza non è più configurabile un danno biologico o morale per il soggetto leso”.
Per comprendere al meglio i principi fissati dalla Suprema Corte attraverso la pronuncia sopra richiamata, occorre analizzare la norma anche in riferimento al profilo funzionale della rendita.
L’art. 2057 stabilisce che presupposto essenziale per il riconoscimento della rendita è la sussistenza di un danno biologico accertato, a carattere permanente. La costituzione della rendita vitalizia è disciplinata dall’art. 1872 del c.c. Essa si configura come un contratto aleatorio di durata e ad esecuzione periodica, commisurata alla vita di un soggetto. Nel caso in cui tale strumento venga utilizzato come forma di ristoro dei danni – a differenza di quello della liquidazione di una somma a titolo di capitale una tantum – realizza, ad avviso dei giudici della Corte di Cassazione, una migliore modalità di liquidazione, evitando il rischio che ingenti capitali possano andare dispersi per mala fede o inesperienza dei familiari. Inoltre, il valore della rendita non sarà computato in base alla speranza di vita del danneggiato ma in virtù della vita futura prevedibile secondo gli schemi di mortalità stilati dall’Istat.
Si aggiunga che nell’ipotesi in cui si opti per la liquidazione del danno sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudicante dovrà determinare le opportune cautele volte a scongiurare il rischio di insolvibilità del danneggiante.
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, precisato che tra i poteri del giudice non figura soltanto quello di optare per la citata modalità di liquidazione del risarcimento, ma anche quello di disporre delle ”opportune cautele funzionali a garantire l’adempimento de die in diem dell’obbligo di versare al danneggiato il rateo di rendita, così come stabilito dall’art. 2057, secondo periodo, c.c.” (come la stipula di una polizza fideiussoria da parte dell’obbligato o disporre dell’acquisto di titoli del debito pubblico), dall’altro il giudice stesso avrebbe comunque l’onere di “assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata, per l’intera durata della vita del beneficiario”.
Di recente anche l’Osservatorio milanese sulla giustizia civile è intervenuto sul tema elaborando delle nuove tabelle per la capitalizzazione del danno da lucro cessante legato alla perdita della capacità lavorativa e non già del danno non patrimoniale come fatto, invece, dai giudici della Cassazione.
Entrambi gli interventi, però, sono ispirati alla stessa politica del diritto che mira a una maggiore equiparazione tra liquidazione in forma di rendita e in somma capitale nel risarcimento del danno alla persona.
Ma come potrebbero incidere sulle compagnie assicurative e sulle strutture sanitarie queste novità relative alla modalità di liquidazione dei danni?
La liquidazione sotto forma di rendita vitalizia dei danni potrebbe coinvolgere in negativo non solo l’assicuratore ma anche il riassicuratore. La compagnia, infatti, oltre a dover stimare l’importo da garantire a riserva, dovrebbe quantificare anche le spese prevedibili, con il rischio di raggiungere costi esorbitanti all’aumentare dell’incertezza. Il frazionamento della liquidazione, inoltre, potrebbe incidere sulla modalità di rendicontazione del risarcimento e sul reperimento delle risorse utilizzate per lo stesso.
Quanto alle strutture sanitarie, invece, l’applicazione della rendita vitalizia potrebbe comportare una crisi dei bilanci, incentivando la concorrenza, anche di tipo assicurativo, delle strutture private dotate di maggiore liquidità, oltre che generare una progressiva perdita di servizi a causa degli alti costi da sostenere.
Si consideri che l’indifferenza della modalità di liquidazione (somma capitale o rendita) assunta dalla giurisprudenza potrebbe essere messa in crisi banalmente già dal fatto che la rendita vitalizia è soggetta a tassazione e che essendo spesso veicolata tramite una polizza, anche questa sarebbe tassata con il paradossale risultato di aumentare il costo del risarcimento svalutando la portata dello strumento.
Non si può, quindi, che auspicare che il legislatore avvii un dibattito serio sul punto, che vada oltre i temi strettamente civilistici, affrontando il tema del risarcimento del danno alla persona in maniera reale anche tenuto conto delle molteplici ricadute economiche e di tutela importanti.
Questo articolo è stato redatto insieme a Mario Del Gaudio.
Scarica qui l’articolo completo in PDF.